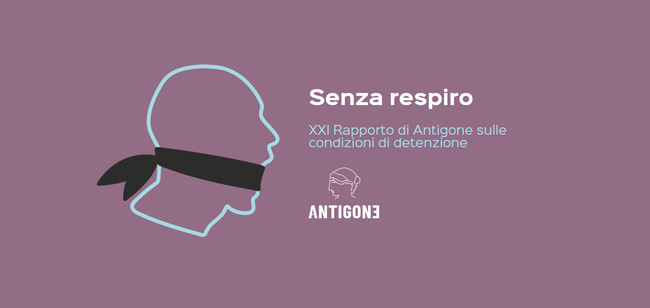Il XXI Rapporto di Antigone restituisce l’immagine di un sistema penitenziario italiano sempre più in crisi. Al 30 aprile 2025, le persone detenute erano 62.445 – rispetto alle 62.427 nel 2024 – un dato in continua crescita che aggrava una situazione già segnata da un sovraffollamento cronico. La capienza regolamentare delle carceri è infatti di poco superiore ai 51.000 posti, ma molti di questi risultano inutilizzabili per via di lavori o inagibilità strutturali. Il tasso reale di affollamento si attesta così attorno al 133%, con punte che superano il 200% in istituti come San Vittore a Milano, Foggia e Lucca.
Se da un lato nei primi mesi del 2025 si è registrata una lieve flessione degli ingressi, dall’altro le politiche penali in atto – orientate verso l’inasprimento delle pene e l’introduzione di nuovi reati – lasciano prevedere un’inversione di tendenza. Intanto, cala lentamente la percentuale dei detenuti in custodia cautelare, pur restando alta, soprattutto tra le persone straniere che continuano a subire questa misura in misura sproporzionata rispetto agli italiani.
Un dato particolarmente significativo riguarda la durata delle pene: più della metà dei detenuti condannati ha meno di tre anni da scontare, una soglia che dovrebbe, almeno teoricamente, favorire l’accesso a misure alternative alla detenzione. Invece, molte di queste persone – spesso fragili, tossicodipendenti, recidive – rimangono in carcere anche per pene inferiori all’anno, per l’assenza di percorsi alternativi efficaci o per la debolezza delle loro difese legali.
Parallelamente, cresce il disagio interno agli istituti. Nel 2024 si è registrato un aumento degli atti di autolesionismo (+4,1%) e dei tentativi di suicidio (+9,3%), mentre i suicidi effettivi sono stati 91, il numero più alto mai registrato in un solo anno. A peggiorare la situazione ha contribuito il ritorno generalizzato al regime di celle chiuse, in aperta contraddizione con le indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Le tensioni si traducono in un’impennata di proteste e atti di disordine: dagli scioperi della fame alle cosiddette “battiture” – ovvero il battere di oggetti metallici contro le grate delle celle – fino ai rifiuti del vitto e alle aggressioni, sia tra detenuti che verso il personale.
Tra i temi centrali del rapporto spicca la questione della presenza straniera in carcere. Al 30 aprile 2025, le persone detenute di nazionalità non italiana rappresentavano il 31,6% della popolazione carceraria, a fronte del 32% del 2024. Una cifra che, se rapportata alla presenza di stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale, non giustifica affatto l’allarmismo spesso diffuso. Si tratta perlopiù di soggetti giovani, economicamente vulnerabili, senza reti familiari o sociali di sostegno, condannati prevalentemente per reati contro il patrimonio. Tuttavia, accedono molto più difficilmente a misure alternative, anche per la cronica mancanza di mediatori culturali e per gli ostacoli burocratici legati alla loro condizione giuridica.
La condizione delle donne detenute, pur rappresentando solo il 4,3% del totale (4,4% nel 2024), è oggetto di particolare attenzione. Dopo la chiusura del carcere femminile di Pozzuoli, restano solo tre istituti interamente dedicati alle donne: Rebibbia a Roma (375 presenze per 272 posti, il carcere femminile più grande d’Europa), la Giudecca a Venezia (102 presenze per 112 posti) e la Casa di Reclusione femminile di Trani (34 presenze per 32 posti). Le altre sono relegate in piccole sezioni all’interno di carceri maschili, spesso isolate e prive di attività o percorsi di reinserimento. In generale, le donne accedono con più facilità alle misure alternative, grazie anche alla minore gravità dei reati e alla presenza di figli. Al 31 marzo 2025, erano 15 i bambini che vivevano in carcere con le madri. Tuttavia, il nuovo decreto sicurezza ha modificato profondamente le tutele per le madri detenute, abolendo l’automatico rinvio della pena per chi ha figli piccoli e introducendo persino la possibilità di separare la madre dal figlio in caso di comportamenti ritenuti inadeguati.
Sul fronte dei diritti affettivi, si registra un cambiamento significativo. Per la prima volta, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha emanato una circolare specifica per regolare gli incontri intimi tra detenuti e partner, recependo una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il controllo visivo durante i colloqui. È un passo avanti nel riconoscimento del diritto all’intimità, ma l’applicazione concreta resta incerta: molti istituti non dispongono di spazi adeguati e l’accesso resta vincolato a requisiti selettivi, con esclusione di chi è sottoposto a regimi speciali o sanzioni disciplinari.
La situazione più critica riguarda però i minori. Al marzo 2025, gli Istituti Penali per Minorenni (Ipm) ospitavano 597 ragazzi, mentre a fine 2024 erano 587 – un numero in forte aumento anche a causa del Decreto Caivano, che ha inasprito le misure cautelari e ampliato l’area del penale per i minori. In almeno nove Ipm (su 17 presenti nel territorio) si registra sovraffollamento. È sintomatica la creazione, a Bologna, di una sezione minorile all’interno di un carcere per adulti, in palese violazione del principio di separazione tra i due sistemi. Le proteste dei ragazzi – spesso causate dalla carenza di attività educative o da condizioni materiali precarie – vengono sempre più spesso represse con misure disciplinari o penali. Cresce anche l’allarme per il massiccio ricorso a psicofarmaci negli Ipm, il cui uso in alcuni istituti ha subito un’impennata impressionante.
Infine, il lavoro e la formazione, che dovrebbero essere strumenti fondamentali per il reinserimento, restano largamente insufficienti. Nel 2024 solo il 28,4% dei detenuti risultava occupato, e appena il 5% lavorava per datori esterni. Anche la formazione professionale, pur in crescita, coinvolge ancora una minoranza. I corsi più attivi sono quelli in ambito culinario, edile e agricolo, ma mancano investimenti strutturali e gli incentivi previsti per le aziende che assumono detenuti rimangono poco utilizzati.
In conclusione, il sistema penitenziario italiano appare sempre più come un luogo di sofferenza e marginalizzazione, dove la risposta repressiva tende a prevalere su quella rieducativa. Le alternative esistono – dal lavoro ai percorsi formativi, dal diritto all’affettività a quello alla genitorialità – ma continuano a restare fuori dalle mura delle carceri.
Vedi anche
Le stanze dell’amore all’interno del carcere. Correlazione tra intimità e riabilitazione
“Fine pillola mai”: una inchiesta congiunta per indagare l’uso degli psicofarmaci negli IPM