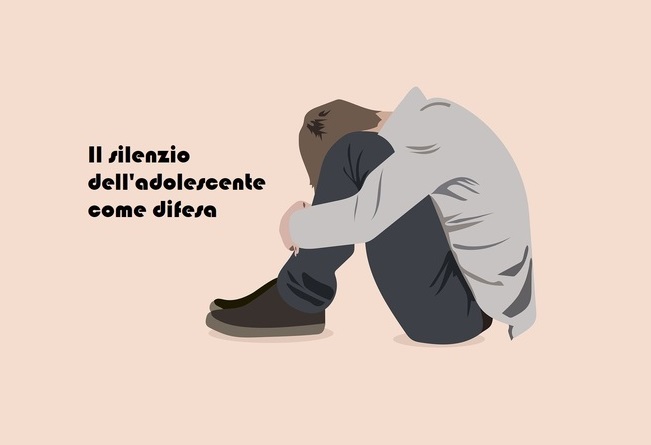Quando ci si ritrova ad avere un figlio con delle fragilità i genitori iniziano giustamente a preoccuparsi poiché, queste fragilità, a volte, portano a delle conseguenze anche abbastanza gravi nel comportamento della loro prole.
Durante l’approccio terapeutico non sempre si può stabilire un contatto, o meglio una complicità col paziente.
L’alleanza con esso diventa fondamentale per ottenere dei risultati proficui. Invece molte volte quest’ultimo tende a chiudersi nel suo mondo o meglio nelle sue convinzioni, la principale delle quali è che non si ha bisogno dei genitori per trovare la propria identità tra i pari. Questa barricata fa sì che il figlio sia, come lo definisce Friedlander, un ostaggio della terapia.
Arma e unico strumento utilizzato dal paziente per “difendersi” è il silenzio.
Ma fuggendo dalle categorie cosa ci aiuta a smarcarci da esse?
L’umanità dell’approccio terapeutico. Grazie ad essa si evitano parole come diagnosi, problema e soluzione che oltre a categorizzare, allarmano parecchio i pazienti. Durante una terapia familiare cercare un’interazione tra le persone è il primo antidoto per rompere il ghiaccio. “Valorizzare l’ostaggio” facendo domande sui punti di forza di colui che si barrica dietro il silenzio, aggiunge una marcia in più alla manovra che porta al contatto e al dialogo. Ciò aiuta a non colpevolizzarlo e a farlo allontanare dal meccanismo del pregiudizio innescato dai suoi genitori che tendono a non esprimere i loro sentimenti ma ad accusare il figlio. I veri punti innovativi sono la già citata umanità e la libertà di espressione nella relazione.
È questo equilibrio che crea non una cura ostracizzante ma una inclusiva.
Per approfondimenti: L’adolescente silenzioso nella seduta di terapia familiare, in La famiglia che cura.