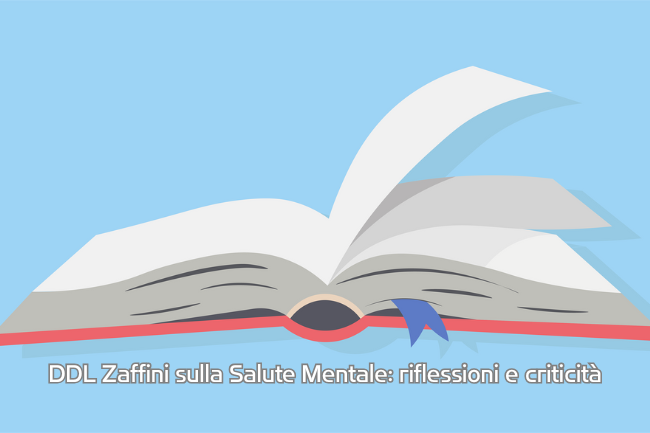Francesco Zaffini di Fratelli d’Italia è il primo firmatario di un DDL sulla salute mentale in esame presso la Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato. Un Disegno di legge che, attraverso la proposta di nuove disposizioni in materia di salute mentale, rischia però di produrre non solo un arretramento rispetto alla fondamentale Legge 180 (la cosiddetta Legge Basaglia) ma di incrementare significativamente da un lato le misure di carattere limitativo delle libertà individuali, dall’altro di aumentare le risorse a favore delle iniziative di carattere privatistico senza nulla aggiungere ad un sistema di servizi in crisi di risorse e di personale.
Tra le voci critiche rispetto al DDL qualcuna si è spinta addirittura a parlare di manicomietti. Abbiamo voluto quindi leggere il DDL per intero. L’impressione generale è che il provvedimento proposto non sia troppo incisivo sulle questioni critiche che pure sono presenti nel mondo dei servizi per la salute mentale: spinge più che altro su un malinteso tema di sicurezza e propone una maggiore attenzione alle tematiche della prevenzione che, infine, si traducono solo in uno stanziamento di alcuni milioni di euro rivolto a sostenere non si capisce bene quali interventi o prestazioni. Andiamo per ordine.
Il DDL non comincia male: richiamando in premessa la trasformazione delle forme di sofferenza mentale (sommariamente elencate più che analizzate) e l’incremento numerico delle persone che ne soffrono; a fianco a questo ricordando che, a dispetto di quanto stabilito in Conferenza Stato Regioni già nel 2001, il finanziamento dei servizi per la Salute Mentale non ha mai conseguito la soglia del 5% rispetto al totale per il SSN: attestandosi al massimo al 3%.
I toni si fanno però da subito allarmanti, in quanto, come anticipato, la parola chiave più volte richiamata è quella della “sicurezza”. Sicurezza dei pazienti ma anche dei loro familiari e quindi degli operatori socio-sanitari. Sicurezza, incolumità, violenza: chi ha familiarità con la storia della salute mentale non può non cogliere il riecheggiare di quel concetto di pericolosità sociale che si sovrapponeva a quello di follia.
Torniamo a note positive (siamo ancora alle premesse) quando si invoca la diagnosi precoce attraverso l’individuazione del disturbo mentale sin dalla preadolescenza: attraverso la disposizione di modalità di collaborazione che coinvolgano la famiglia, i servizi sanitari e quelli educativi.
Passando all’articolato, una certa enfasi viene posta sugli interventi di prevenzione intesi come diagnosi precoce, in età minorile, e presa in carico precoce: attraverso la comprensione all’interno dei DSM dei servizi di salute mentale dell’età evolutiva.
Per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi, sostanzialmente si fotografa la situazione che si è venuta delineando negli anni; solo mettendo “a sistema” la ricomprensione dei servizi per le dipendenze e le tossicodipendenze all’interno dei DSM.
Lo stesso può dirsi per quanto riguarda le figure professionali dei servizi per la salute mentale: vengono ricomprese quelle che via via, negli anni, hanno declinato le professionalità su cui si incardinano i diversi servizi. Nel comma 2 dell’articolo 4 si torna però ad occuparsi di sicurezza: quella, specificamente, degli operatori socio-sanitari. Il concerto con i Ministeri dell’Interno e della Giustizia; la previsione (motivata, certamente) di misure e trattamenti coattivi farmacologici, fisici, e ambientali: anche se riconosciamo che il problema possa esistere (non dissimilmente peraltro da analoghe situazioni nei pronto soccorsi, nei reparti di degenza ospedaliera; o, aggiungeremo, nelle istituzioni scolastiche), l’eco della Legge Crispi è piuttosto vivo. Suona addirittura inquietante quel richiamo alle misure di contenimento ambientale che, mal interpretato, sa di celle di sicurezza o celle imbottite.
Venendo alle situazioni di emergenza, urgenza e crisi, vengono richiamate le disposizioni vigenti in termini di ASO e TSO: solo (solo?) aumentando la durata “ottimale” del TSO dagli attuali 7 giorni fino a 15. Nessun riferimento viene invece fatto alla questione dell’intervento di convalida del giudice tutelare (su cui si è espressa di recente la Corte Costituzionale); e appare superflua e costituzionalmente insufficiente la sottolineatura che la proposta di TSO debba essere convalidata da un medico.
Per quanto riguarda i rapporti con l’amministrazione penitenziaria, se è nell’ordine delle linee normative già esistenti che si organizzi e si potenzi l’assistenza psichiatrica in carcere, appare sufficientemente fuori luogo (letteralmente e logicamente) che si preveda anche la possibilità di TSO in carcere: mentre attualmente il TSO dei carcerati è destinato comunque (sia pure con immaginabili difficoltà organizzative) al regime ospedaliero (SPDC). Del resto, varrà la pena ricordarlo, la S della sigla TSO sta per Sanitario: e non è sostenibile che il carcere possa essere inteso come luogo di trattamento clinico.
Una prima lettura del DDL ha generato un certo allarme per quanto riguarda l’accento posto sulla “residenzialità”. Si tratta però del riconoscimento di strutture comunque esistenti, che con diverso grado di intensità ed estensività sono già utilizzate nell’ambito delle politiche pubbliche per la salute mentale. Nell’ambito della residenzialità appare invece rilevante che si preveda, in caso di necessità o comunque di opportunità di allontanamento della persona con sofferenza mentale dal suo ambito familiare, che si debbano individuare opportunità alloggiative nell’edilizia residenziale pubblica. al momento lo consideriamo un ottimo auspicio: resta da vedere se sarà accompagnato da corrispondenti interventi a favore delle politiche per la casa.
E per quanto riguarda i finanziamenti? Avevamo preso atto che la premessa del DDL lamentasse la distanza tra il previsto, il programmato e l’erogato per quanto riguarda la spesa dedicata alla salute mentale. Negli ultimi articoli vengono definiti alcuni stanziamenti specifici, destinati a campagne di informazione, attività formative e poi, con un valore ben più importante, al rimborso per le spese sostenute direttamente per gli interventi precoci negli stati mentali a rischio nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza: tutto piuttosto vago, probabilmente da rimandare ad atti di definizione da parte del potere esecutivo. E per i servizi? C’è ancora da attendere.